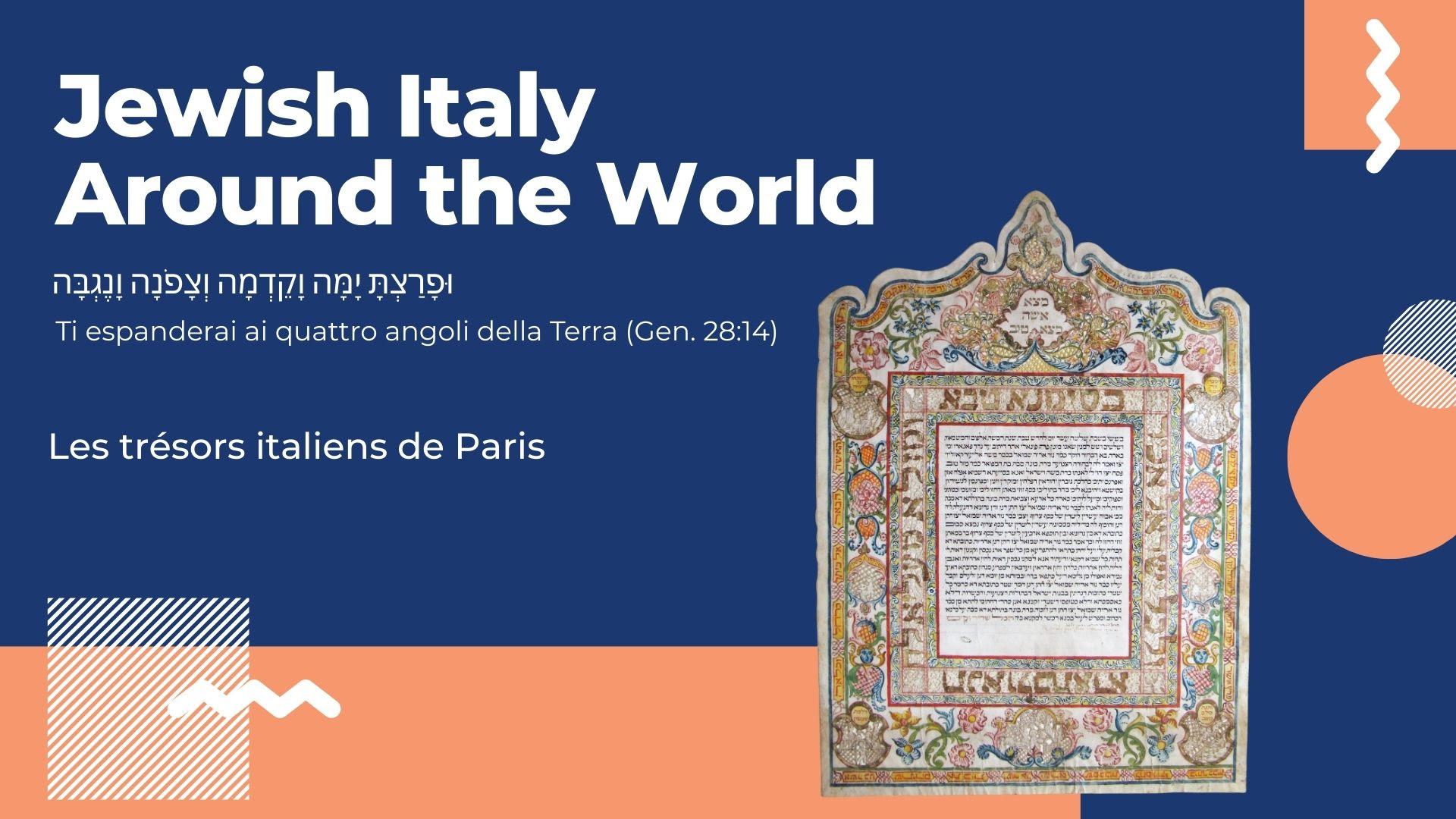Il Rinascimento parla ebraico. Una mostra in corso a Ferrara
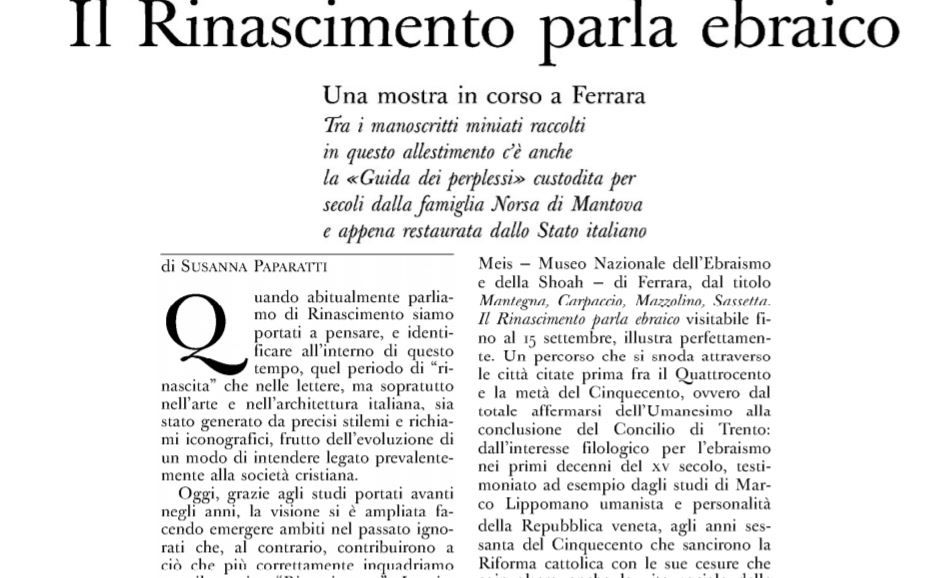
di SUSANNA PAPARATTI
Quando abitualmente parliamo di Rinascimento siamo portati a pensare, e identificare all’interno di questo tempo, quel periodo di “rinascita” che nelle lettere, ma sopratutto nell’arte e nell’architettura italiana, sia stato generato da precisi stilemi e richiami iconografici, frutto dell’evoluzione di un modo di intendere legato prevalentemente alla società cristiana. Oggi, grazie agli studi portati avanti negli anni, la visione si è ampliata facendo emergere ambiti nel passato ignorati che, al contrario, contribuirono a ciò che più correttamente inquadriamo con il termine “Rinascimento”.
La vita nelle città, il rapporto storico e culturale che si andava via via delineando fra le corti, in virtù di mirati matrimoni, avevano contribuito a un travaso culturale al quale le diverse comunità ebraiche presenti in Italia intendevano a giusto titolo prendere parte: in un contesto di rinnovata tradizione cristiana e identità giudaica. Firenze, Ferrara, Mantova, Venezia, Genova, Pisa, Napoli, Palermo e Roma erano alcune realtà nelle quali le comunità giudaiche erano già presenti in ruoli di primo piano, eppure non sempre visti senza pregiudizi, nonostante alcune delle posizioni da essi ricoperte fossero determinanti: non mancavano infatti all’appello medici, mercanti e prestatori. L’operato di questi ultimi, ancora alla fine del Trecento e agli inizi del secolo successivo, era svolto da altri, sino al declino progressivo che lasciò ai banchieri ebrei ampio spazio, affinando conoscenze e rapporti finanziari che in molti casi segnarono l’ago della bilancia della storia, facendo assumere ai banchieri un ruolo socioeconomico paragonabile a quello dell’alta borghesia e della nobiltà cristiana.
Il Rinascimento è dunque stato frutto di esperienze diverse che sono riuscite a integrarsi, talvolta con fatica, con scontri ideologici, con momentanee e brusche chiusure ma sicuramente dando vita a un dinamismo culturale del quale la mostra in corso al Meis — Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah — di Ferrara, dal titolo Mantegna, Carpaccio, Marzolino, Sassetta. Il Rinascimento parla ebraico visitabile fino al 15 settembre, illustra perfettamente. Un percorso che si snoda attraverso le città citate prima fra il Quattrocento e la metà del Cinquecento, ovvero dal totale affermarsi dell’Umanesimo alla conclusione del Concilio di Trento: dall’interesse filologico per l’ebraismo nei primi decenni del xv secolo, testimoniato ad esempio dagli studi di Marco Lippomano umanista e personalità della Repubblica veneta, agli anni sessanta del Cinquecento che sancirono la Riforma cattolica con le sue cesure che coinvolsero anche la vita sociale delle comunità ebraiche. La rassegna in corso si sofferma sul dialogo culturale e sociale intercorso fra gli ebrei italiani e la società circostante, per la gran parte di matrice cristiana. Fra i luoghi dove gli appartenenti alle comunità ebraiche vivevano e lavoravano, nelle sinagoghe dove ci si raccoglieva in preghiera, narrandone i mestieri, gli studi e le arti in cui eccellevano: compresa quella esoterica della Qabbalah. Raccolte in questa esposizione concentrata su un periodo determinante per la storia di quella che sarebbe diventata l’identità italiana, oggetti quotidiani, manoscritti miniati ebraici, pergamene, dipinti mai esposti sin ora fra i quali spiccano quelli firmati da illustri maestri: pitture a soggetto religioso cristiano nelle quali probabilmente non ci aspetterebbe trovare al loro interno evidenti richiami all’ebraismo, come scritte sui copricapi, nelle vesti o in parti architettoniche.
Ecco dunque del Mantegna la Sacra famiglia e famiglia del Battista (1504-1506), la Nascita della Vergine (1502-1507) di Vittore Carpaccio, di Ludovico Mazzolino la Disputa di Gesù con i dottori del Teempio (1519-1525), del Sassetta Elia e Eliseo. Tra i manoscritti miniati ebraici, di fattura e opulenza rinascimentale, la Guida dei perplessi, custodita per secoli dalla famiglia Norsa di Mantova, recentemente acquistata e restaurata dallo Stato italiano; il cosiddetto “Codice Maimonide”, manoscritto del medico e filosofo ebreo Mosheh ben Maimon, poi l’arredo sinagonale ligneo italiano più antico esistente l’aron ha-qodesh (“Arca Santa”) e la bimah (pulpito) di Modena del 1472, tornati in Italia per la prima volta da Parigi; il Rotolo della Torah di Biella del XIII secolo che, antichissima pergamena della Bibbia ebraica, è letta tutt’oggi durante le liturgie in sinagoga e ancora alcune traduzioni di scritti cabalistici di Pico della Mirandola giunti dalla Biblioteca Vaticana. La rassegna si divide in sezioni ordinate al loro interno mediante criteri cronologici, di distribuzione geografica e di sinergia intellettuale. Curata da Giulio Busi e Silvana Greco l’esposizione in corso è la seconda allestita negli spazi del Meis che nel 2017 ha inaugurato la sua sede con la mostra Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni, in entrambi i casi parte del materiale costituirà quella che diverrà l’esposizione permanente della struttura.
Altri contenuti

12 febbraio, evento online
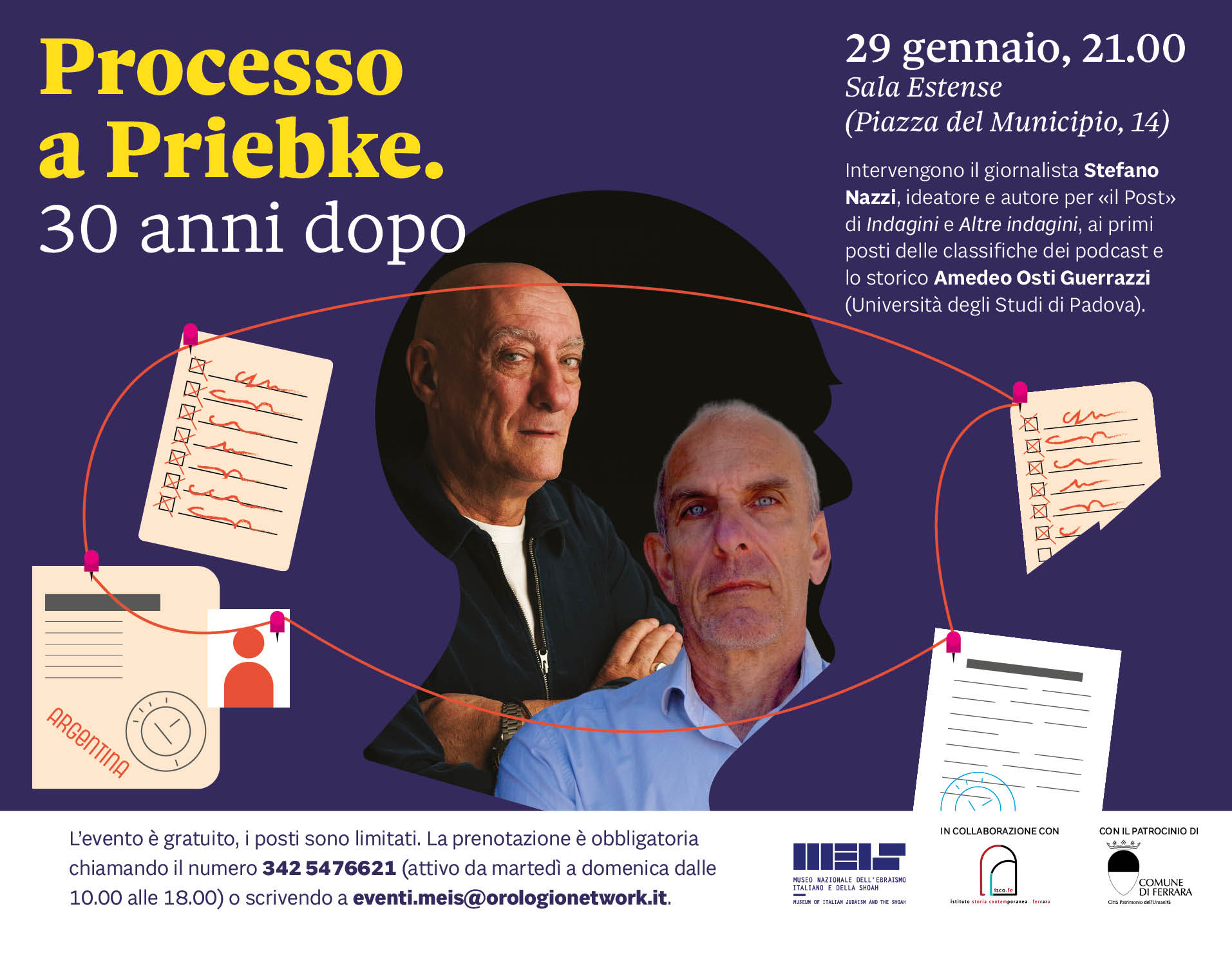
Giorno della Memoria 2026, il calendario degli eventi

Giorno della Memoria 2026, il programma per le scuole

Viaggio alla scoperta del Salento ebraico