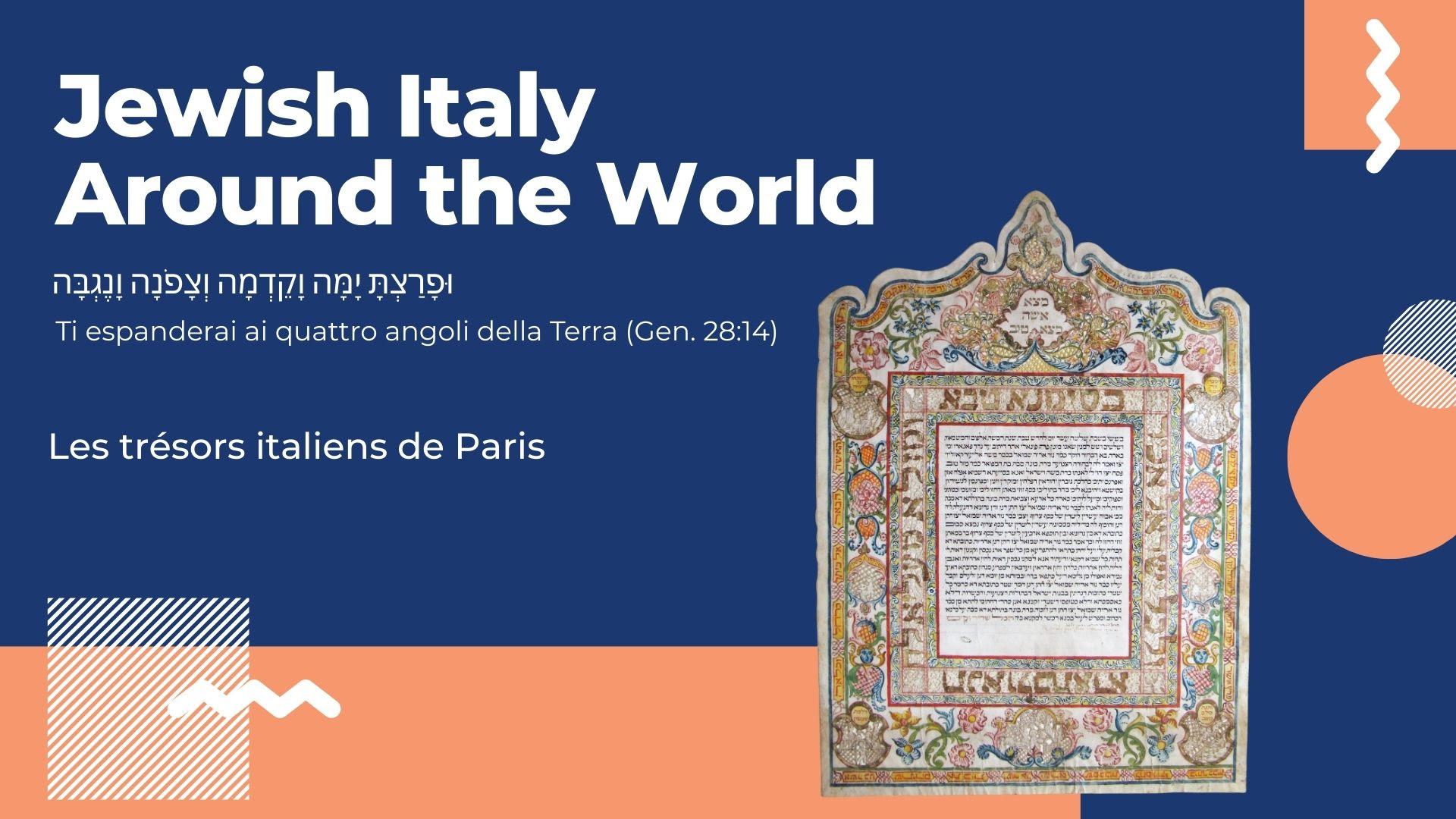25 aprile, Note sul contributo degli ebrei alla Resistenza

In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia vi proponiamo il saggio di Liliana Picciotto “Note sul contributo degli ebrei alla Resistenza” pubblicato nel catalogo della mostra del MEIS “Ebrei nel Novecento italiano” (Sagep, 2024) curato da Vittorio Bo e Mario Toscano.
Buon 25 aprile!
Nessuna notizia del mondo, o degli amici. L’isolamento è completo […]. Pensiamo ai nostri cari, agli amici lontani […] tutti nello stesso pericolo tutti alla macchia, se pur hanno fatto a tempo a sfuggire dalle spietate mani dei nazisti. Penso ai giovani che sono con i partigiani e vorrei essere con loro… Mi piacerebbe far pagare cara la mia pelle ai tedeschi… Ma al momento della scelta …ho deciso di rimanere vicino a mamma. Non mi è possibile abbandonarla, esporla da sola ai pericoli del momento (Marcello Morpurgo, Valdirose. Memorie della comunità ebraica di Gorizia, Del Bianco, Udine 1986).
È il giovane ventiquattrenne di Gorizia, Marcello Morpurgo, rifugiato con la madre, Gilda Luzzatto, a Treviso, presso una generosa famiglia amica, a fornire questo sintetico quadro della situazione dei giovani ebrei tra il 1943 e il 1945, stretti tra la necessità di proteggere, in qualche modo, la famiglia e quella di unirsi alla Resistenza.
Mai come allora, le famiglie furono costrette a ripiegarsi su sé stesse. La cosa importante era salvarsi, la Resistenza veniva dopo. La questione della custodia della famiglia è un tema peculiare agli Ebrei: per loro, l’emergenza era collettiva, riguardava tutti, compresi anziani e bambini, non era individuale come per il resto degli italiani. La compagine dei partigiani era costituita da militanti politicizzati, soprattutto comunisti e azionisti, ma la massa era composta da ragazzi che non risposero ai pressanti bandi per il richiamo alla coscrizione militare delle classi 1923-1924-1925 del ministro della guerra Rodolfo Graziani, del novembre del 1943 e del febbraio del 1944, con tanto di minaccia di fucilazione per i renitenti.
Un altro grande apporto ai primi nuclei partigiani lo portarono i giovani coscritti: dopo l’8 settembre 1943, privi di ordini superiori, si sbandarono e, per non essere arrestati dai militari tedeschi e deportati, dovettero cercare di raggiungere le loro case per nascondersi o, comunque, passare nella clandestinità. La Resistenza, ancora embrionale nell’autunno-inverno del 1943-1944, si ingrossò presto con questi giovani in cerca di una soluzione per sopravvivere e non cadere nelle mani di tedeschi e fascisti che davano loro la caccia.
Più generalmente parlando, i moventi che guidarono le persone verso la Resistenza furono la stanchezza della guerra, la domanda di pace, la cacciata dei tedeschi, la speranza di un futuro migliore. Per gli ebrei, il movente principale era invece istantaneo, pressante, privo di visione del futuro, era sopravvivere. In queste condizioni, desta stupore l’alto numero di giovani ebrei che decisero di unirsi alla Resistenza. Un calcolo, del tutto impressionistico, fa ammontare il loro numero a un migliaio di persone. Se così fosse, e ci sono buone probabilità, in futuro, di verificare tale dato, stiamo parlando di un’altissima percentuale. La comunità ebraica per intero, infatti, contava alla vigilia dell’occupazione tedesca, secondo valutazioni basate su dati certi, poco meno di 39.000 persone. La percentuale di resistenti, a diverso titolo, sarebbe dunque del 25 per mille della popolazione.
La famiglia fu per gli ebrei una discriminante e, attraverso questa lente di ingrandimento, dobbiamo considerare la loro adesione o non adesione alla Resistenza. Fu uno degli elementi determinanti per “la scelta”. Per gli ebrei stranieri provenienti dai Paesi a oriente dell’Europa presenti in Italia, l’opzione fu facilitata dal fatto che si trovavano qui come singoli, avevano studiato in Italia, la famiglia era lontana e spesso, da tempo, non ne avevano più notizie. Erano stati internati nel 1940 in remoti paesini dell’Abruzzo, delle Marche o in altre regioni. La scelta fu più facile, dovevano decidere solo per sé stessi. Inoltre, molti si trovavano in Italia, respinti dalle università dei loro paesi, e avevano conseguito la laurea in medicina, utile ai combattenti (Geremia Gerecht, Herbert Gottschalk, Leopoldo Grinberg, Jacob Heliczer, Isacco Heger, Giuseppe Kovacs, Rodolfo Propst, Sauro Rotenstreich, Carlo Schönheim, Janina Stromberg, Felix Szajkowics ed altri).
Anche per i rifugiati in Svizzera, la famiglia fu la discriminante, solo dopo averla sistemata al sicuro, parecchi rientrarono per combattere (Federico Almansi, Alessandro Cantoni, Eugenio Cassin, Giorgio Cingoli, Renzo Coen, Sergio Coen, Giorgio Colorni, Luigiotto Da Fano, Sergio Diena, Gino Donati, Gino Faldini, Franco Fortini, Elia Leone Nissim, Gianni Pavia, Davide Pugliese, Gianfranco Sarfatti, Gianni Segre Reinach, Umber to Terracini, Sergio Valobra, Piero Vitali ed altri). La partecipazione degli ebrei alla Resistenza fu declinata in tutte le sue sfaccettature: dalla militanza politica antifascista alla partecipazione alla lotta armata, dall’impegno a trovare strategie per salvare le famiglie, all’opera di soccorso organizzata in favore di altri ebrei in pericolo. La lotta degli ebrei per la loro sopravvivenza è da ricomprendere nel concetto stesso di resistenza, una questione assente all’interno di un campo di studi pur ampiamente esplorato.
Nel libro, classico, di Claudio Pavone: “Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza”, si confrontano tre tipi di conflitti: la guerra patriottica, la guerra di classe e la guerra civile. In questa scansione, dove sono gli ebrei? Di che guerra fanno parte? Quale erano i loro obiettivi immediati, dato per scontato che nessun futuro si prospettava loro di fronte alla radicalità degli scopi dei nazisti e dei loro collaboratori italiani? A questa e ad altre domande darà risposta una ricerca sul contributo degli Ebrei alla Resistenza, iniziata, sotto la mia guida, dalla Fondazione CDEC nel 2021 e giunta a metà del suo cammino, essendone prevista la pubblicazione sotto forma di libro nel 2025. Per ora, i dati raccolti sono pubblicati nel portale Resistenti Ebrei d’Italia, continuamente implementato man mano che la ricerca progredisce.
Qui accenniamo ai principi che hanno informato lo studio, gli obiettivi che si è proposto, la metodologia usata e segnaliamo qualche risultato parziale. Intendo per Resistenza l’insieme delle azioni, organizzate o no, individuali o no, armate o no, tendenti a contestare l’ordine costituito imposto dall’occupante tedesco e dai suoi alleati politici italiani (la Repubblica Sociale Italiana), in vista della liberazione nazionale e del ristabilimento dei principi democratici. Fu un grande movimento, il primo spontaneo e collettivo degli italiani, dopo anni di consenso alla dittatura.
Per afferrare meglio il fenomeno, mi sono, prima di tutto, imposta di condurre un censimento nazionale degli ebrei che si sono uniti alla Resistenza: quali i loro nomi; da che famiglia provenivano; la loro età; i legami famigliari; dove possibile, anche le professioni o il grado di studi e le preferenze politiche. Sono stati individuati fino ad oggi 416 cittadini ebrei resistenti: 6 in Campania (le Quattro giornate di Napoli); 145 nel Lazio; 100 in Toscana; 24 in Abruzzo; 34 nelle Marche; 8 in Umbria; 67 in Emilia-Romagna; 32 in Liguria. Mancano alla ricerca le grandi regioni del Nord, dove maggiore era la presenza ebraica; perciò, si pensa di raggiungere facilmente il migliaio di persone sopra accennato, se non di più. Dei 416 finora individuati, le donne furono solo 39. Un piccolo numero, anche se il loro apporto fu fondamentale: molte dottoresse o addette ai servizi sanitari, qualche insegnante, parecchie staffette, perfino una combattente caduta in montagna durante un rastrellamento fascista, insignita, più tardi, di medaglia d’oro, Rita Rosani. Le donne ebree hanno pagato, come tutte le donne, il fatto di essere considerate troppo deboli ed esposte per essere accettate nel novero dei resistenti. Curiosamente, quella ebraica è più o meno la stessa percentuale di donne, riscontrata nella Resistenza generale. 531.560 furono i partigiani riconosciuti ufficialmente come tali, di cui, le donne furono 32.164.
Tra le resistenti ebree, mi piace nominare almeno Lea Loewenwirth, ragazzina sedicenne, che mentendo e ingannando le autorità, condusse con coraggio, attraverso l’Europa in fiamme, i genitori e i sei fratellini da Anversa a Nizza, poi nelle valli di Cuneo attraversando a piedi le Alpi Marittime, in seguito a Firenze e infine a Roma. Della famiglia si perse solo il padre, arrestato a Firenze.
Tra i 416 resistenti, 37 furono i caduti in combattimento o durante una rappresaglia. 12 di essi furono invece catturati e destinati non già al campo di Auschwitz come gli altri ebrei, ma al campo di concentramento di Mauthausen, come tutti gli altri deportati politici dall’Italia.
Importante è anche l’analisi delle date di nascita. Mentre per la maggioranza dei partigiani l’età media si aggira intorno ai 20, 21 e 22 anni, sorprendentemente, abbiamo individuato ben 40 resistenti ebrei nati alla fine del XIX secolo, il che vuole dire che durante la Resistenza avevano compiuto 43 anni e più. Il dato è interessante e per ora si possono solo avanzare due ipotesi, ancora da verificare: erano persone di una certa cultura e già orientate politicamente in senso antifascista e, quando giunse l’ora, si dettero da fare per fiancheggiare la Resistenza, oppure erano persone abituate alle armi perché avevano combattuto nella Prima guerra mondiale e misero a disposizione della Resistenza il loro sapere militare.
D’altra parte, abbiamo identificato 14 giovanissimi partigiani ebrei sotto i 17 anni, tra i quali: Franco Cesana, nato nel settembre del 1931 e morto nel settembre del 1944, non ancora tredicenne e l’altro, meno noto, adolescente bolognese di nome Raffaele Del Vecchio, morto sedicenne.
Una delle fonti principali del nostro studio è stata l’immensa cartoteca nominativa costituita dai cartellini di riconoscimento di status di partigiano da parte di Commissioni regionali ad hoc istituite nell’immediato dopoguerra, 1945 e 1948, e della Commissione Unica Nazionale nel 1968, per determinare la qualifica di quelli che ne facevano domanda. Sono, da qualche anno (2009-2012), patrimonio dell’Archivio Centrale dello Stato e fanno parte del fondo archivistico, cosiddetto Ricompart, ‘Riconoscimento Qualifiche e Ricompense ai Partigiani’.
I cartellini sono serviti come base di partenza della nostra ricerca, ma sono laconici: portano solo il cognome e il nome della persona riconosciuta ‘partigiano combattente’ o ‘partigiano combattente caduto’ (o patriota se la collaborazione alla lotta fu marginale). Compaiono poi: le date di nascita, i nomi dei genitori (non sempre), la regione di attività e la formazione partigiana di cui la persona stessa faceva parte. Occorreva approfondire, capire se la persona in questione era di origine ebraica e formulare una, seppur concisa, biografia partigiana. Per questo ci siamo avvalsi di un’altra fonte preziosa, costituita dal Fondo ‘Antifascisti e partigiani ebrei’ conservato nell’archivio della Fondazione CDEC. È, questo, il frutto di una pionieristica ricerca avviata nel 1955 dalla Federazione Giovanile Ebrei d’Italia – FGEI e che costituisce uno dei nuclei generativi dell’ormai immenso attuale archivio della Fondazione. Un’altra fonte è costituita dalle migliaia di testimonianze spontanee, orali e scritte, depositate presso l’archivio CDEC e dalle centinaia di interviste ad ebrei anziani realizzate negli ultimi anni. Sono stati inoltre consultati tutti i libri di memoria comparsi dal dopoguerra ad oggi.
Con lo studio comparato delle fonti si è determinato un giacimento di notizie da cui poter attingere per meglio interpretare i fatti a conclusione della ricerca. Quel che è certo è che si poteva militare con le armi (Bruno Cevidalli, Mario Levi, Alba Cesarina Padoa, Piero e Vittorio Sacerdoti, Matilde Bassani ed altri), con la propria pratica medica (Renzo Calabresi, Mosè Di Segni, Rinaldo Laudi, Arri go Finzi, Carlo Coen Giordana, Renzo Coen ed altri), con carta e penna (Leone Ginzburg, Cesare Colombo, Paolo Alatri, Liana Millul, Eucardio Momigliano e altri), con la dinamite (Giorgio Formiggini, Pino Levi Cavaglione, Alessandro Sinigaglia ed altri), cospirando politicamente (Vittorio Foa, Leo Valiani, Umberto Terracini, Eugenio Colorni, Bruno e Gino Pincherle ed altri), procurando ad altri ebrei in pericolo false identità (Giorgio Nissim, Settimio Sorani, Massimo Teglio, Mario Finzi, Giorgio Kropf, Enzo Levi, Carlo Morpurgo, Raffaele Jona ed altri).
Un accenno va fatto anche a quegli ebrei italiani che, trovandosi fuori d’Italia, si arruolarono volontari nell’esercito inglese per essere paracadutati oltre le linee e lavorare come agenti di collegamento o portando pesantissime e rischiose ricetrasmittenti (Enzo Sereni, Luciano Servi, Renato Levi ed altri), così come ai volontari che, trovandosi già al sicuro nell’Italia meridionale, si arruolarono nei cosiddetti Gruppi di Combattimento che appoggiavano gli eserciti alleati (Mario Attilio Levi, Giorgio Richetti, Sauro Valobra, Aldo Passigli ed altri). Molti altri temi andranno messi sul tappeto: in che rapporto stavano i vertici della Resistenza con la questione della persecuzione antiebraica e la Shoah? C’era cognizione del pericolo mortale in cui versava la popolazione ebraica? La Resistenza ne fece un suo tema di interesse? E, ancora, ci furono offerte politiche che i resistenti Ebrei privilegiavano? Erano essi interessati ad aderire a una formazione piuttosto che ad un’altra? E se sì, ciò avvenne solo nelle regioni settentrionali, dove più forte era il peso della politica nella Resistenza?
Concludo questa breve presentazione con le parole di Gilberto Coen che, al momento di lasciare Losanna per rientrare in Italia a combattere (e a morire), il 16 maggio 1944, scrisse ai genitori ignari: “… bisogna che anche tu, mamma, capisca tutto questo. Poiché è necessario di inquadrarlo nella durezza atroce dei tempi che viviamo. Ditemi voi: chi, se non io, deve combattere questa guerra? Forse che un giovane inglese, od un americano od un neo-zelandese ha più ragioni di me di prendere le armi in pugno? Tutto ha una suprema logica a cui sarebbe delittuoso volersi sottrarre. Ma siate sereni e fieri di me, che ho avuto tanta fortuna da realizzare le mie sane aspirazioni… Vi abbraccio con tutto l’affetto di cui è capace il vostro Gilberto”.
Nella foto: Pino Levi Cavaglione, comandante partigiano, Genova 1943. In B. Migliau e M. Di Gioacchino, Centocinquant’anni in un percorso per immagini tra storia e memoria, in «La Rassegna Mensile di Israel», gennaio-agosto 2010, Vol. 76, nn. 1/2, pp. 359-426: 394, foto 28
Altri contenuti

12 febbraio, evento online
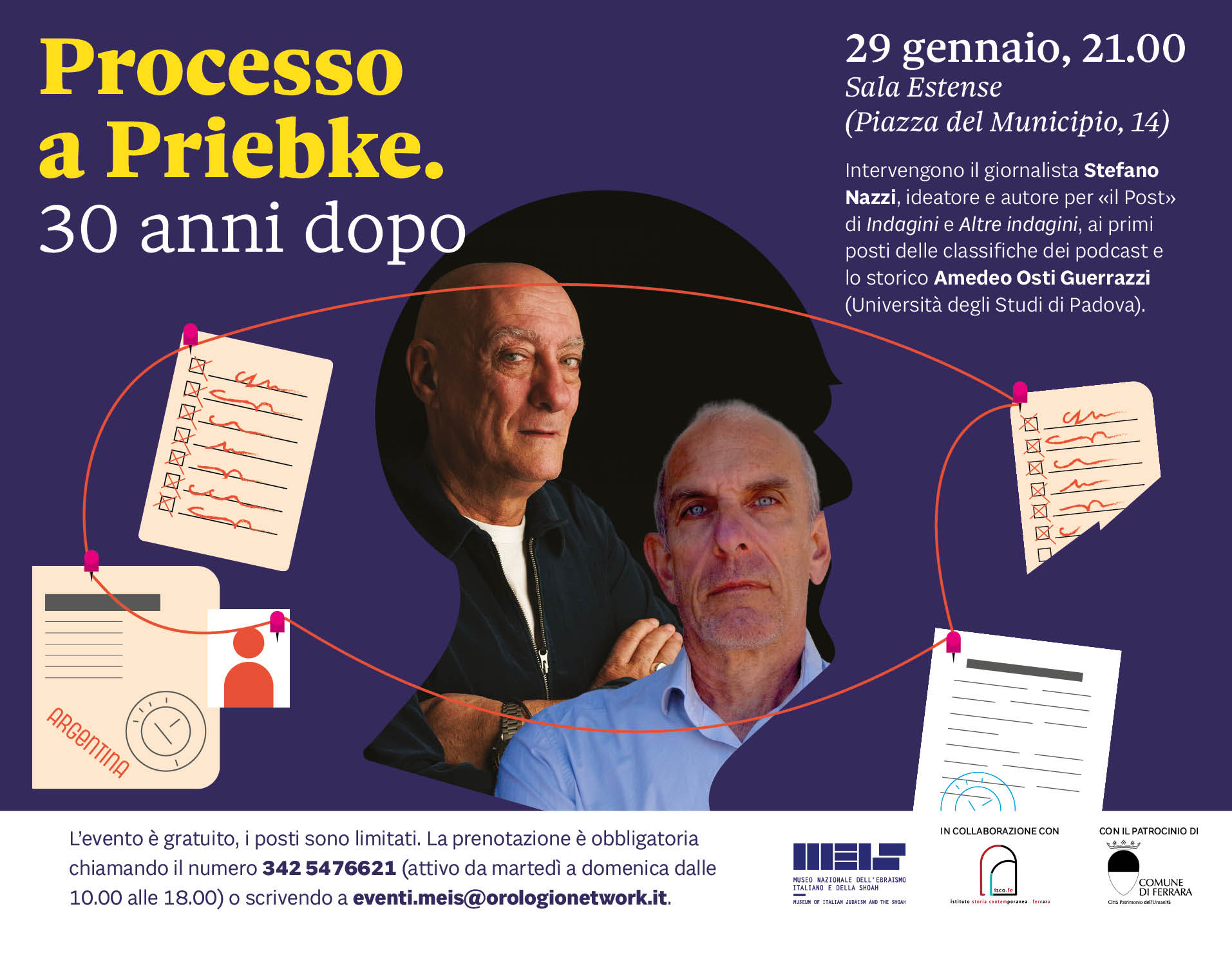
Giorno della Memoria 2026, il calendario degli eventi

Giorno della Memoria 2026, il programma per le scuole

Viaggio alla scoperta del Salento ebraico