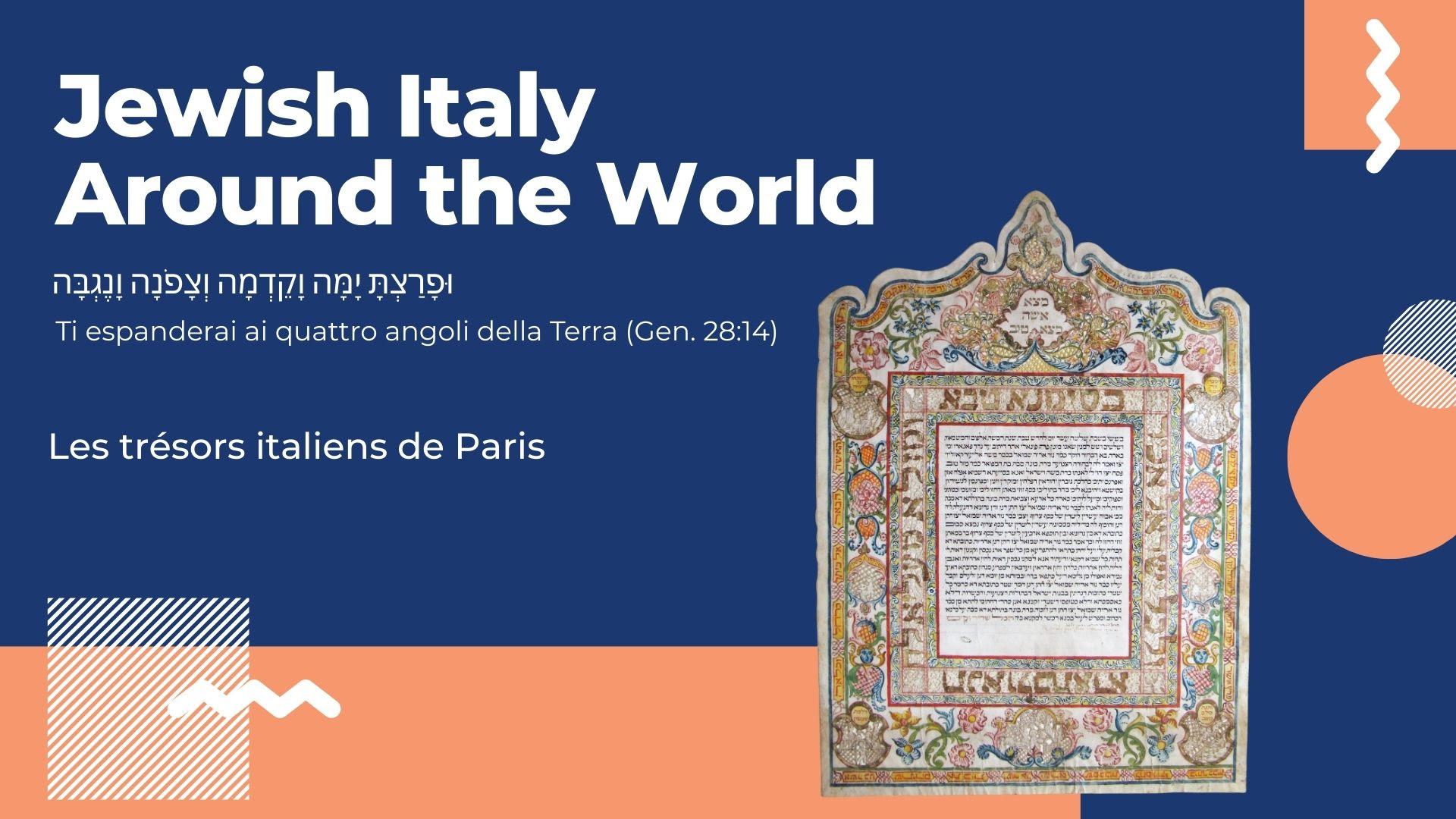1938, le leggi razziali e gli italiani che non erano brava gente

«C’è la tendenza a fare cose senza ricordare il passato, quello che è già stato». Risponde così il giornalista e scrittore Fabio Isman alla domanda se trova nel presente segni di quel passato che racconta in 1938, l’Italia razzista edito dal Mulino. Durante la presentazione al Meis, il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, tornerà in altri due momenti a riportare al presente quanto accaduto agli ebrei italiani dal 1938 in poi.
«Le date contano», spiega, «non fu solo dal 1943, quando cominciò la deportazione, ma fin dal 1938 quando furono promulgate le leggi razziali i 50mila ebrei italiani subirono una persecuzione severa.
Gli italiani si accorsero di essere brava gente solo quando si portavano via le vite».
Prima c’era ben altro: istanze ai prefetti per occupare le case degli ebrei fuggiti, richieste per diventare amministratori dei beni sequestrati agli ebrei. L’Egeli era l’ente di gestione e liquidazione dei beni immobiliari confiscati, istituito nel 1938, è stato liquidato nel 1957 e definitivamente soppresso nel 1997. Solo nel 1998 è stata costituita dal governo italiano una Commissione relativa all’«acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati». La presiedeva Tina Anselmi.
«Negli archivi», dice Isman, «c’è la documentazione della persecuzione degli ebrei». Erano 420 le leggi razziali. Sempre si ricorda l’esclusione dalle scuole, ma ce ne sono decine di altre. «Agli ebrei era impedito di allevare colombi viaggiatori, di insegnare danza, di consociarsi come professionisti se non ci fosse stato anche un ariano nella società».
Poi ci furono confische e sequestri. «Il valore è almeno 150 milioni di euro odierni, senza contare i furti e quanto sequestrato nelle zone del Nord Italia controllate direttamente dai tedeschi». Tutto comincia con le leggi razziali dell’agosto del 1938 partite con un censimento (qui all’autore vengono i brividi pensando al censimento dei Rom proposto ben più di recente). «Auto che non funzionano, conti in banca da 1,5 lire in su, azioni, gioielli, persino gli abiti e le mutande sporche, tutto deve essere denunciato».
Le denuncia di appartenenza alla razza ebraica era dappertutto, dalle pagelle ai documenti e impediva, per esempio, di dormire in albergo a Cortina, ma anche di fare pubblicità. «Per la maggioranza fascisti non erano preparati, non se lo aspettavano da un governo che avevano sostenuto e che qualche anno prima aveva dato vita all’Unione delle Comunità Ebraiche. Solo nel 1938 dopo la visita di Hitler a Roma cambiò e infatti le leggi razziali arrivarono poco dopo».
Da qui un continuo aumento di provvedimenti, che gli ebrei italiani accettarono. Vietato recensire libri tedeschi di autori ebrei, via gli ebrei stranieri, fuori docenti e alunni ebrei dalle scuole pubbliche. Erano vietate la pesca e la villeggiatura, lo sport e la citazione nell’elenco del telefono. Erano di fatto espulsi dal contesto sociale. «Dei beni della famiglia di Liliana Segre furono messi all’asta i macchinari dell’impresa del padre per appena 5mila lire, lo zio fu risarcito di 26mila lire per gli appartamenti di Corso Buenos Aires».
Nel 1943 gli ebrei non potevano più possedere niente. Il ritmo era di 16 confische al giorno, l’ultima il 24 aprile del 1945, il giorno prima della liberazione. «Per loro restavano la fuga all’estero, ma per andare in Svizzera si dovevano dare almeno 10mila lire a un contrabbandiere che poteva venderti a un tedesco, e la latitanza, sempre a rischio delazione». È questo il secondo punto in cui l’autore fa cenno ad avvenimenti molto vicini che gli fanno venire i brividi. «Primo Levi», scrive Liliana Segre nella prefazione, ci ha per sempre messi sull’avviso: “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo”».
Altri contenuti

12 febbraio, evento online
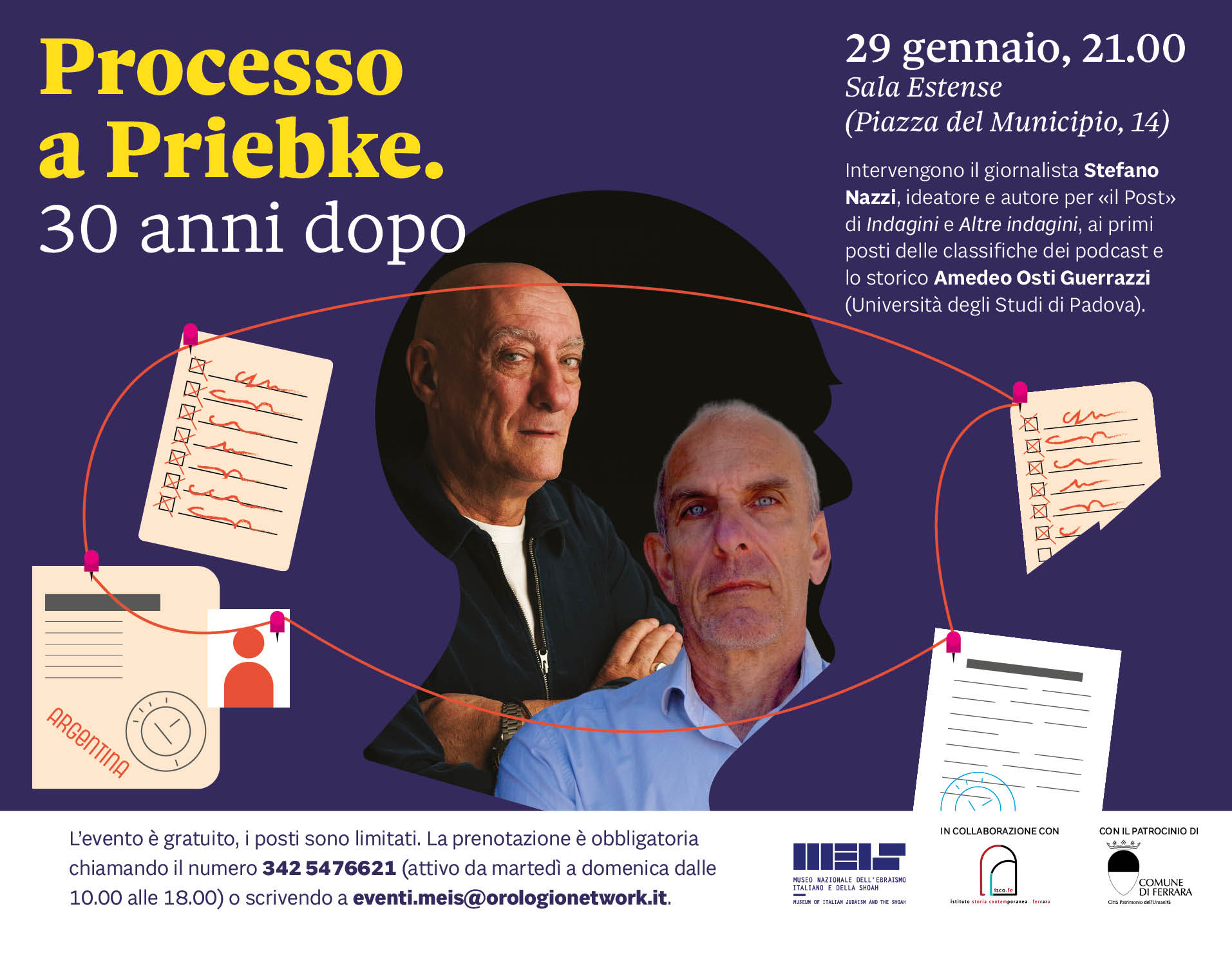
Giorno della Memoria 2026, il calendario degli eventi

Giorno della Memoria 2026, il programma per le scuole

Viaggio alla scoperta del Salento ebraico