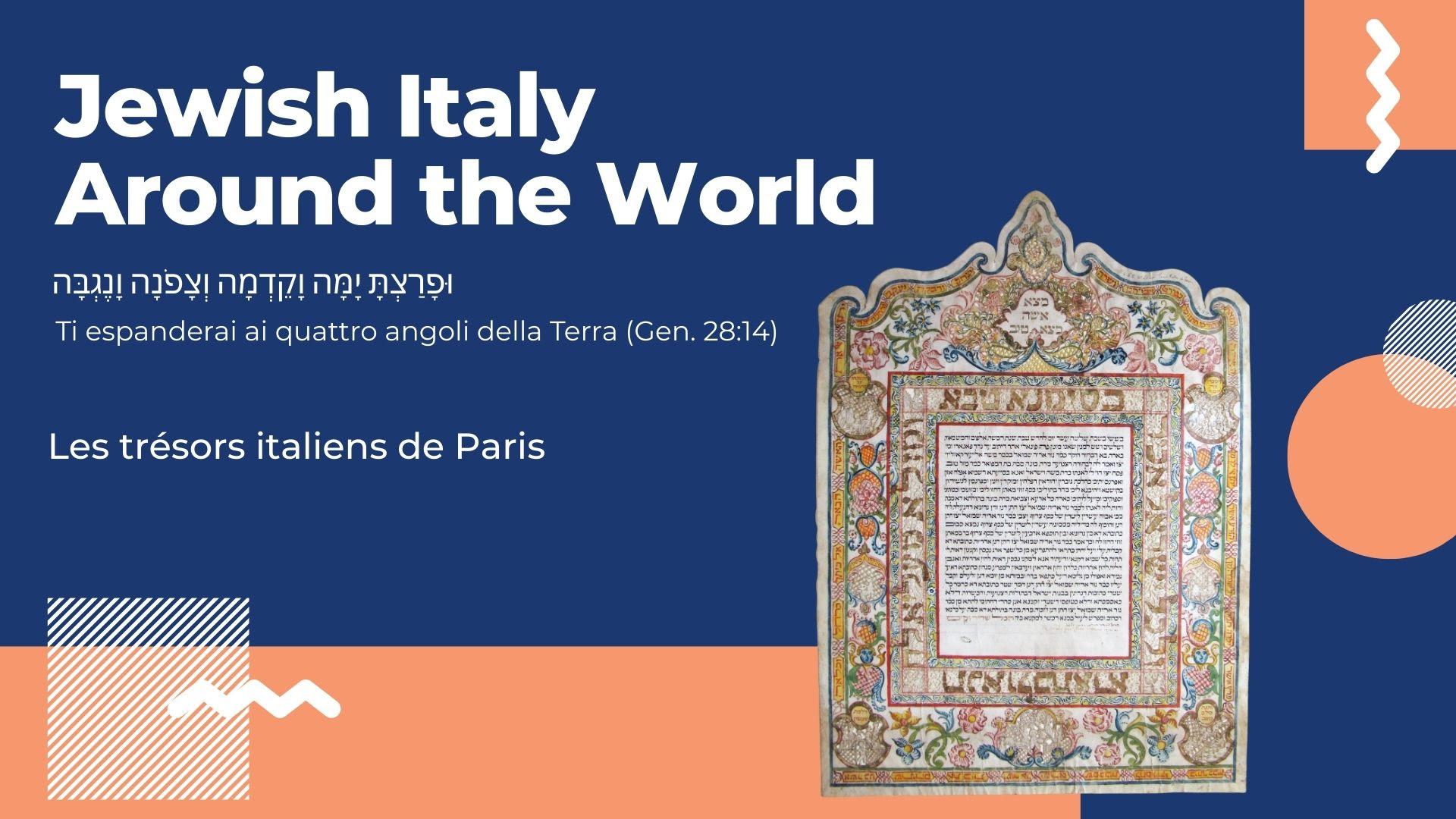Liliana Segre racconta Auschwitz agli studenti: “Pensavo fosse un incubo”

di Simone Pesci
“Ascoltatemi come nonna”. Liliana Segre esordisce così, di fronte agli oltre 700 studenti che stipano il Teatro Nuovo – e che la accolgono con una lunga standing ovation -, impazienti di sentire il racconto di vita della matricola 75190, una delle ultime sopravvissute ad Auschwitz. All’incirca, Liliana aveva la stessa età che hanno gli studenti che oggi la ascoltano con il fiato trattenuto.
“Ero una bambina qualunque, viziata come io vizio ora i miei nipoti, che a 8 anni si sentì dire che era stata espulsa da scuola e che non poteva frequentare la terza elementare” ricorda Segre, che torna con la mente a quei terribili giorni che iniziarono a segnare per sempre la vita degli ebrei italiani.
“Mi chiesi – prosegue – perché con gli occhi pieni di lacrime, e ancora oggi non ho trovato risposta. Casa mia diventò improvvisamente triste, e ricordo i poliziotti che entravano prepotentemente per controllarci i documenti. Ci trattavano da nemici della patria, la cui unica colpa era quella di essere nati”.
Allo scoppio della guerra la famiglia Segre si trasferì in un paesello della Brianza, dove Liliana ricorda che “ero l’unica che non andava a scuola, e allora io dicevo che dovevo occuparmi di mio nonno, malato di Parkinson. Amavo stare con lui”. Dopo l’8 settembre 1943 il padre tentò di nasconderla da alcuni amici, anche se “io non volevo abbandonare la mia famiglia e non ero grata a chi cercava di nascondermi, lo sono diventata dopo”. Liliana e il padre provarono la fuga verso la Svizzera, ma un ufficiale svizzero-tedesco “ci disse che eravamo persone infime e ci riportò al confine, dove fummo arrestati. Come entra una tredicenne in carcere? Piangevo, e mi chiedevo il perché”.
I Segre lasciarono il carcere di San Vittore il 30 gennaio 1944: “Su quel trasporto partito dal binario 21 della stazione centrale di Milano fummo in 605 e tornammo in 22. Ci caricarono su un carro bestiame, senza luce, senz’acqua, solamente con un secchio. Eravamo 40-50 persone in ogni vagone e c’era odore di urina, paura e morte. Il viaggio durò una settimana e sviluppò in tre fasi: inizialmente piangevano tutti; in una seconda fase gli uomini religiosi iniziavano a radunarsi per lodare Dio, ma negli ultimi due giorni ci fu un silenzio essenziale, di quando si sta per morire. Arrivati ad Auschwitz il silenzio si contrappose ai tanti rumori e iniziò la grande selezione della Shoah, che non fu una cosa istintiva ma programmata da anni”.
Mentre lancia una stoccata ai negazionisti – “a un orrore talmente indicibile è più facile non crederci” – e rivela qualche attacco ricevuto sul web – “ma poi mi trovo davanti voi e ho la mia coscienza” -, Segre nota qualche studente parlottare e ridacchiare: “Se – li riprende quasi sottovoce – non avete voglia di ascoltare, invito i vostri insegnanti a farvi uscire. Io non mi offendo ma non c’è niente da ridere”.
Passato lo spiacevole inconveniente, il racconto si fa concitato: “Dopo la separazione fra uomini e donne, ci dissero che dopo la registrazione ci saremmo ritrovati. Invece fummo selezionati, di quelle 605 persone selezionarono 31 donne e una settantina di uomini. Quando entrai nel campo di Birkenau-Auschwitz e vidi il crematorio, le baracche e le persone scheletrite pensavo di essere in un incubo”.
Il destino riservò a Segre un posto “da schiava-operaia in una fabbrica di munizioni, ma fu una fortuna lavorare al coperto in quegli inverni”, e soprattutto il passaggio di “tre selezioni, nell’anno che rimasi ad Auschwitz”.
Proprio una selezione rappresenta uno dei momenti più significativi della senatrice: “I Kapo, dopo averti denudato, controllavano le tue condizioni ed eri grata al tuo assassino quando ti lasciava in vita. In fabbrica lavoravo come inserviente di Jeanine, una ragazza francese. Due giorni prima della selezione un macchinario le tranciò due dita, mentre io mi rivestivo felice sentii che la fermarono dietro di me. Non mi sono voltata, non le ho fatto coraggio, non l’ho salutata e il giorno dopo al suo posto c’era un altra persona. I miei assassini erano riusciti a farmi diventare una lupa affamata ed egoista. Fui orribile, vigliacca”.
La marcia della morte, a cui fu costretta anche Segre, diventa però una sorta di insegnamento per il presente: “Mi chiedevo come Liliana avesse fatto a macinare tutti quei chilometri. Ragazzi, non dite mai che non ce la fate più, non è vero. Siamo fortissimi e dobbiamo trasformare la marcia della morte nella marcia della vita, che potete plasmare per gran parte con le vostre mani. Abbiate coraggio e orgoglio di come siete senza ascoltare i bulli, chi fa il bullo è quello che da grande può fare il Kapo, hanno la stessa consistenza. Sono i più fragili che hanno bisogno di dire che sono forti, i forti non ne hanno bisogno”.
Altri contenuti

12 febbraio, evento online
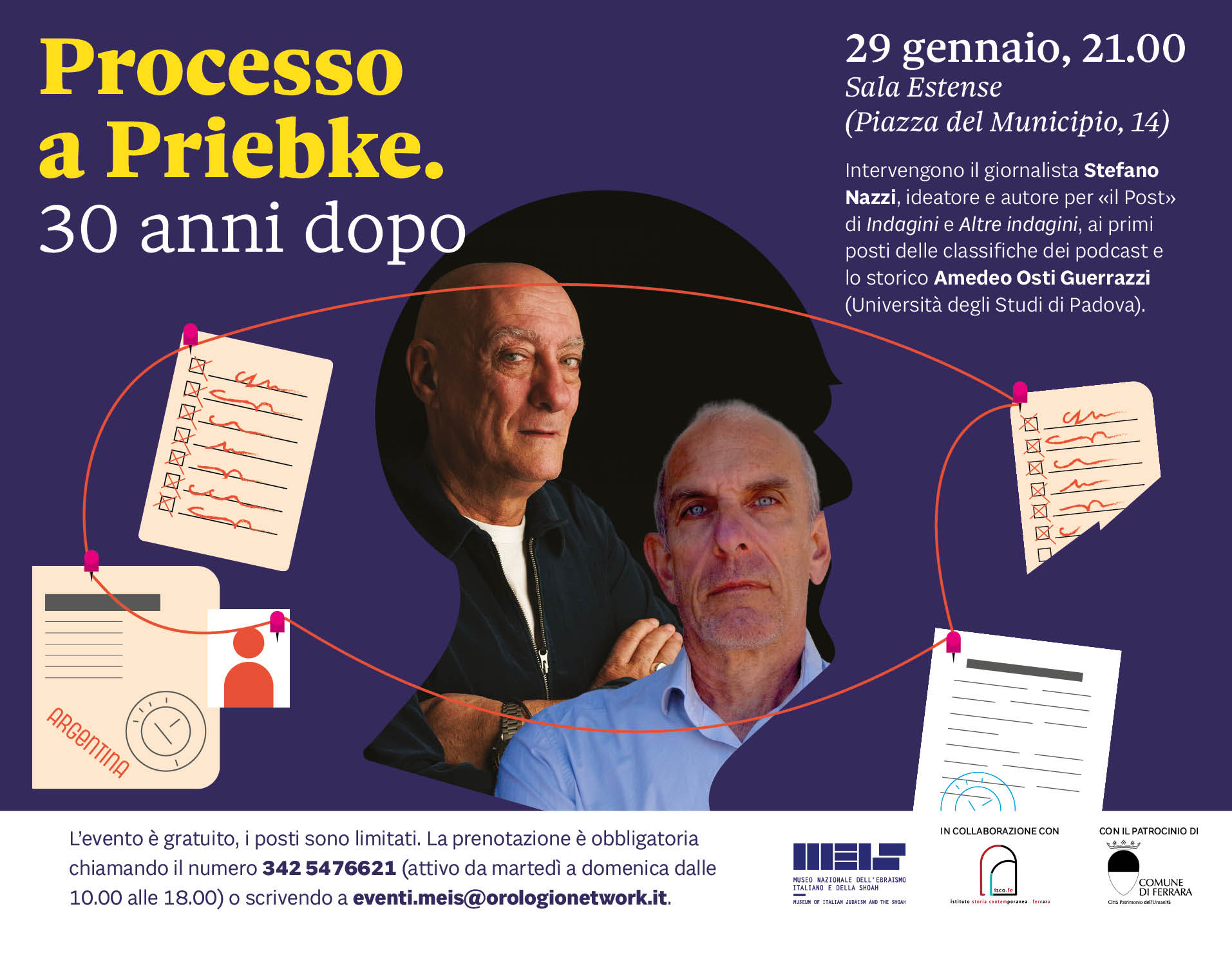
Giorno della Memoria 2026, il calendario degli eventi

Giorno della Memoria 2026, il programma per le scuole

Viaggio alla scoperta del Salento ebraico